 |
| Una foto della via
dell'Acquedotto, attuale viale XX Settembre, agli inizi del '900. |
MESTIERI DELLA TRADIZIONE
El ciccio
LA CICCERIA
English
[Tratto da: La Biblioteca del
Piccolo, [data?]
p. 27-29.]
Il ciccio proveniva dalle montagne, da terre arse e
brulle
percorse solamente da greggi di
pecore e agnelli ed era un montanaro slavo
[no, era rumeno]
cappello a tesa larga, palandrana di griso castagna
senza maniche, calzoni stretti di griso bianco e ciabatte basse dette
opanche. Si diceva arrivasse dalla Cicceria ovvero dalla "terra dei
Cicci", localizzando tale altipiano nella parte alta dell'Istria, una zona
elevata rispetto al livello del mare e ricca di boschi dai quali i
cicci traevano grandi quantità di
legna da ardere e di carbone dolce.
Con l'appellativo cicci si soleva indicare i romanici del Carso, così
come cicerani o ciribiri indicava quelli sotto Monte Maggiore,
berchini
quelli del distretto di Castelnuovo, besiachi i croati,
fucki i villani del Pìnguentino, bodoli
gli isolani del Quarnero e maurovlahi i dalmati montanari dell'agro
parentino o polesano.
La figura del ciccio
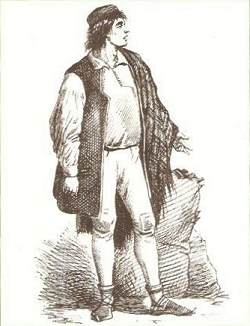 |
|
Sopra ed a destra,
un ciccio e una ciccia tratti dalla serie di costumi e mestieri di
Eugenio Bosa. |
|
|
Il ciccio arrivava a Trieste portando con sé pesanti
sacchi dentro i quali c'era la merce da vendere, ossia fascetti di
legno e carbon dolce. Al grido di "Carbuna!
Carbuna! Fassi!" le massaie triestine accorrevano e il ciccio
iniziava la vendita, mostrando loro piccoli campioni dei vari tipi
di legna. Forte, resistente al freddo, al caldo e alla fame,
il ciccio
giungeva nelle piazze di mercato, superando non poche difficoltà e
vi rimaneva solamente per il tempo necessario alla vendita dei
propri prodotti, per poi ritornare con il piccolo guadagno nella
propria casa nascosta tra le montagne. Il ciccio apparteneva a quegli slavi[zzati] istriani
che amavano la propria indipendenza domestica, gente che non voleva
esercitare arti o professioni di sorta, ma continuare il mestiere
dei propri avi, tramandandolo di generazione in generazione. Essi,
infatti, non alteravano gli usi e i costumi della propria razza, non
vestivano mai, neppure d'inverno, il braccio destro, che rimaneva
coperto dalla sola manica della camicia, dando quasi l'impressione
di essere in procinto di lotta oppure pronti alla fuga.
A Trieste, il ciccio era benvoluto e accettato, sebbene la sua attività
fosse considerata dai triestini assai umile, forse la più umile di quelle allora
esercitate, così, con quello spirito arguto e mordace che sempre ha
contraddistinto il popolo tergestino, i triestini ironizzavano un po' sui
cicci e sulla Cicceria e, dovendo dare un giudizio negativo su di una
persona ritenuta incapace, solevano così affermare: "Va la, bon de niente!
ciccio no xe per barca!", con
un detto ancor oggi molto in uso.
Il ciccio svolse la propria attività in quell'epoca che non
conosceva né il gas, ne l'energia elettrica, né gli impianti di
riscaldamento nelle case, ma solamente fogoleri,
stue e forni a legna per la panificazione domestica.
Il montanaro slavo
[no, rumeno]
vendeva carbone ma anche cerchi di legno,
fabbricati artigianalmente nei periodi invernali; talvolta veniva
accampagnato dalla ciccia, la propria moglie, La donna portava
in spalle dei grandi cesti colmi di verdure, oppure dei cerchi di
legno. La ciccia aveva il capo ricoperto da una cuffietta di canapa,
ai piedi le opanche e indossava un pastrano lungo fino allo
ginocchia, che copriva la pesanto gonna ei calzettoni
di lana.
I cicci si occupavano, oltre che di produzione del carbone dolce,
anche di pastorizia, del trasporto di vino, sale e olio dalla costa sino alle
zone interne della Carniola. La figura del
ciccio appartiene ormai a un'altra epoca, quasi a un altro mondo, quello
in cui le nostre nonne e bisnonne erano intente a mettere le spizze nelle
stue (stufe) e a "sufiar su le
bronze" perché "el fogo
ciapi" le fascine, un mondo in cui le nostre nonne e bisnonne correvano
leste in strada al grido: "Carbuna! Carbuna e fassi!".
|